2008 - 2011
Dalla mostre: "Gabbie per signora", Torino, Palazzo Bertalazone di San Fermo, 2010 e Venezia, Magazzini del sale, 2011
Testi
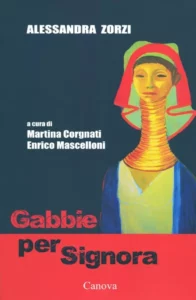 Non ce lo saremmo mai aspettati, in questo nostro mondo evoluto, avanzato, informato e civilizzato. Invece, quasi all’improvviso, veniamo a scoprire che alle minacce presenti, alle sempre nuove potenzialità distruttive che la tecnica continuamente mette in campo e impone come al mondo sotto forma di soglia sempre nuova da superare, si aggiungono gli incubi del passato, la sopraffazione pura, tribale, arcaica, ma non per questo meno crudele. Strano: la nostra buona educazione, la nostra political correctness ci aveva insensibilmente spinto a chiamare “abitudini” o finanche “tradizioni” certe pratiche di sopruso, di offesa o perfino di mutilazione e di deformazione permanente operate ai danni di malcapitati/e locali che, da qualche parte, venivano praticate. Ma, proprio perché le avevamo chiamate così, ci eravamo in fondo convinti che si trattasse di qualche particolarità lontana, qualche fenomeno residuale e marginalissimo, in via di estinzione naturale come gli aborigeni d’Australia, illuminati e quindi assimilati grazie alla nuova, irresistibile ondata del post-illuminismo tecnocratico. Invece no, che sorpresa. Magari gli aborigeni si sono estinti davvero, e magari non in maniera così naturale, ma questo genere di pratiche continua, anzi si estende. Per esempio sembra che nel mondo le donne che hanno subito l’infibulazione siano circa 130 milioni e che 40.000 di queste vivano in Italia. Insomma, più o meno gli abitanti della città di Vercelli e qualcuno di più di quelli di Treviso. Ci colpisce anche che un lavoratore incensurato di origine pachistana residente vicino a Brescia, abbia potuto sgozzare la figlia ventenne perché vestiva all’occidentale e non voleva sottostare ai diktat preparati per lei della tradizione; emulato, poco tempo dopo, da un altro, questa volta marocchino, a Pordenone e altri ancora. Ai mostri della violenza tecnica, delle bombe intelligenti, dei war-games veri e della proliferazione nucleare, si sommano altri mostri che sembravano scomparsi o superati per sempre: feroci clan familiari impegnati in radicali pulizie etniche, crudeltà domestiche, stupri di massa, abiti che feriscono, altri che umiliano, altri che deformano. E, guarda caso, grandissima parte di questi dinosauri brutalmente ritornati ad infestare il mondo, sono nati e concepiti per attacchi o azioni selettive,e rivolte esclusivamente contro le donne. Donne? Sì, donne! è a loro che sono dedicate si può dire in esclusiva la discriminazione sociale di tutti gli integralismi di ritorno, la cecità o il mutismo obbligato delle società neo-tribalizzate, le torture rituali, antiche e moderne, qualche volta con complicazioni estetiche, altre volte religiose, altre volte iniziatiche. È a su di loro che si scatena la frustrazione e il fallimento personale dei maschi messicani di Ciudad Juárez, l’infamia del dowdy crime che i tribunali indiani non riescono a condannare, il disprezzo di padri e fratelli di Peshawar o dei villaggi più poveri nel delta del Nilo, il funesto rigore dei talebani di Kandahar. E se per caso ci incorresse di pensare che tutto questo altro non fosse che una malaugurata deformazione indotta dalla stressante modernità e che nelle società tradizionali le cose andassero ben diversamente, ahimè un’amara delusione ci attende: i piedi deformati (fior di Loto) delle dinastie cinesi Song, Ming, Qing; i collari di rame dei Pandaung birmani che allungano il collo (solo quello femminile, ça va sans dire: il risultato, la cui cervice non più in grado di sostenersi da sola, resterà incarcerata tutta la vita in collari metallici pesanti molti chili, si chiama donna-giraffa); le gogne per esporre le streghe (prima di bruciarle, come accade ancora in diversi luoghi del mondo); piattelli labiali dell’Etiopia che deformano il labbro inferiore. E chi più ne ha più ne metta. Gran parte di queste torture tradizionali è sopravvissuta integralmente e serenamente ai bulldozer della contemporaneità senza nemmeno che i più politicamente avanzati dei suoi/nostri interpreti protestassero troppo. Si tratta solo di donne, alla fine. C’è stato il femminismo, è vero, ma ormai non è molto più di un residuato bellico inutilizzabile nei termini che andavano per la maggiore trent’anni fa e che, oltretutto, visto sullo sfondo del mondo intero, in altre parole della realtà globalizzata, e non soltanto su quello dell’occidente, non appare più che un’increspatura circoscritta e limitata, le cui conseguenze resistono, per il momento, in costumi e leggi statunitensi, europee e poco altro. Insomma: sembra proprio un destino, una di quelle grandi parabole storiche di fronte a cui non resta che arrendersi, abbandonandosi alla corrente. Qualcuno però non riesce a stare fermo e imbraccia quello che può, che ha a portata di mano, armi, penna, pennello o mouse. Perché è nell’arte e nella cultura che fioriscono ancora zone di sensibilità, di attenzione e di intelligenza storica. Sandra Zorzi abita, ha sempre abitato, una di queste zone. Per questo ha deciso di dedicare un intero, spumeggiante ciclo di lavori a queste Gabbie per signora, antiche soprattutto ma anche moderne che sono in fondo così di moda, anzi non hanno quasi mai smesso di esserlo. La situazione, infatti, si pone in termini diversi dal passato e merita una riflessione speciale : non si tratta più dei “soliti cattivi”, strapotenti e perversi, che, per farsi ancora più largo intorno, menano botte da orbi facendo secche frotte di poveretti, deboli, non in grado di difendersi. No. Piuttosto qui sono cattivi un po’ tutti. Forti ma anche deboli. Antichi e moderni, società tribali e società avanzate si ritrovano fondamentalmente d’accordo su un punto, la sottomissione violenta delle loro dolci metà. “La civiltà di un paese si misura dal trattamento riservato alle donne” diceva non troppo tempo fa Hilary Clinton. Ma evidentemente in pochi la ascoltano o piuttosto tutti si sono abituati a convivere con “gradi” abbastanza bassi. Un po’ come nella città di Ubu, dove la crudeltà è efferata e la carneficina grottesca e dove sulla tragedia prevale il disgusto; oppure nella filmografia del controverso, antipatico e ultimamente alquanto dimenticato Gualtiero Jacopetti, dove quanto di peggio si potesse trovare in materia di donne e di violenza, di sadismo e di orrore, dall’Africa alla Polinesia alla Patagonia, finiva tutto puntualmente e disordinatamente affastellato, in crescendi bizzarri, esotici e crudeli che sfruttavano probabilmente l’effetto shock di immagini disordinate, volutamente “forti”, ma avevano anche colto un nervo scoperto nel contraddittorio rapporto tra tradizione e globalizzazione sfrenata, in fortissimo anticipo su tutti gli altri. Sandra Zorzi non ha mai amato le provocazioni di facile effetto e non ha mai cercato di cavalcare le mode dell’orrido ma sa tenere gli occhi aperti e, per senso di responsabilità, ha sempre cercato di fare in modo che, per quanto possibile, li aprissero anche gli altri.
Non ce lo saremmo mai aspettati, in questo nostro mondo evoluto, avanzato, informato e civilizzato. Invece, quasi all’improvviso, veniamo a scoprire che alle minacce presenti, alle sempre nuove potenzialità distruttive che la tecnica continuamente mette in campo e impone come al mondo sotto forma di soglia sempre nuova da superare, si aggiungono gli incubi del passato, la sopraffazione pura, tribale, arcaica, ma non per questo meno crudele. Strano: la nostra buona educazione, la nostra political correctness ci aveva insensibilmente spinto a chiamare “abitudini” o finanche “tradizioni” certe pratiche di sopruso, di offesa o perfino di mutilazione e di deformazione permanente operate ai danni di malcapitati/e locali che, da qualche parte, venivano praticate. Ma, proprio perché le avevamo chiamate così, ci eravamo in fondo convinti che si trattasse di qualche particolarità lontana, qualche fenomeno residuale e marginalissimo, in via di estinzione naturale come gli aborigeni d’Australia, illuminati e quindi assimilati grazie alla nuova, irresistibile ondata del post-illuminismo tecnocratico. Invece no, che sorpresa. Magari gli aborigeni si sono estinti davvero, e magari non in maniera così naturale, ma questo genere di pratiche continua, anzi si estende. Per esempio sembra che nel mondo le donne che hanno subito l’infibulazione siano circa 130 milioni e che 40.000 di queste vivano in Italia. Insomma, più o meno gli abitanti della città di Vercelli e qualcuno di più di quelli di Treviso. Ci colpisce anche che un lavoratore incensurato di origine pachistana residente vicino a Brescia, abbia potuto sgozzare la figlia ventenne perché vestiva all’occidentale e non voleva sottostare ai diktat preparati per lei della tradizione; emulato, poco tempo dopo, da un altro, questa volta marocchino, a Pordenone e altri ancora. Ai mostri della violenza tecnica, delle bombe intelligenti, dei war-games veri e della proliferazione nucleare, si sommano altri mostri che sembravano scomparsi o superati per sempre: feroci clan familiari impegnati in radicali pulizie etniche, crudeltà domestiche, stupri di massa, abiti che feriscono, altri che umiliano, altri che deformano. E, guarda caso, grandissima parte di questi dinosauri brutalmente ritornati ad infestare il mondo, sono nati e concepiti per attacchi o azioni selettive,e rivolte esclusivamente contro le donne. Donne? Sì, donne! è a loro che sono dedicate si può dire in esclusiva la discriminazione sociale di tutti gli integralismi di ritorno, la cecità o il mutismo obbligato delle società neo-tribalizzate, le torture rituali, antiche e moderne, qualche volta con complicazioni estetiche, altre volte religiose, altre volte iniziatiche. È a su di loro che si scatena la frustrazione e il fallimento personale dei maschi messicani di Ciudad Juárez, l’infamia del dowdy crime che i tribunali indiani non riescono a condannare, il disprezzo di padri e fratelli di Peshawar o dei villaggi più poveri nel delta del Nilo, il funesto rigore dei talebani di Kandahar. E se per caso ci incorresse di pensare che tutto questo altro non fosse che una malaugurata deformazione indotta dalla stressante modernità e che nelle società tradizionali le cose andassero ben diversamente, ahimè un’amara delusione ci attende: i piedi deformati (fior di Loto) delle dinastie cinesi Song, Ming, Qing; i collari di rame dei Pandaung birmani che allungano il collo (solo quello femminile, ça va sans dire: il risultato, la cui cervice non più in grado di sostenersi da sola, resterà incarcerata tutta la vita in collari metallici pesanti molti chili, si chiama donna-giraffa); le gogne per esporre le streghe (prima di bruciarle, come accade ancora in diversi luoghi del mondo); piattelli labiali dell’Etiopia che deformano il labbro inferiore. E chi più ne ha più ne metta. Gran parte di queste torture tradizionali è sopravvissuta integralmente e serenamente ai bulldozer della contemporaneità senza nemmeno che i più politicamente avanzati dei suoi/nostri interpreti protestassero troppo. Si tratta solo di donne, alla fine. C’è stato il femminismo, è vero, ma ormai non è molto più di un residuato bellico inutilizzabile nei termini che andavano per la maggiore trent’anni fa e che, oltretutto, visto sullo sfondo del mondo intero, in altre parole della realtà globalizzata, e non soltanto su quello dell’occidente, non appare più che un’increspatura circoscritta e limitata, le cui conseguenze resistono, per il momento, in costumi e leggi statunitensi, europee e poco altro. Insomma: sembra proprio un destino, una di quelle grandi parabole storiche di fronte a cui non resta che arrendersi, abbandonandosi alla corrente. Qualcuno però non riesce a stare fermo e imbraccia quello che può, che ha a portata di mano, armi, penna, pennello o mouse. Perché è nell’arte e nella cultura che fioriscono ancora zone di sensibilità, di attenzione e di intelligenza storica. Sandra Zorzi abita, ha sempre abitato, una di queste zone. Per questo ha deciso di dedicare un intero, spumeggiante ciclo di lavori a queste Gabbie per signora, antiche soprattutto ma anche moderne che sono in fondo così di moda, anzi non hanno quasi mai smesso di esserlo. La situazione, infatti, si pone in termini diversi dal passato e merita una riflessione speciale : non si tratta più dei “soliti cattivi”, strapotenti e perversi, che, per farsi ancora più largo intorno, menano botte da orbi facendo secche frotte di poveretti, deboli, non in grado di difendersi. No. Piuttosto qui sono cattivi un po’ tutti. Forti ma anche deboli. Antichi e moderni, società tribali e società avanzate si ritrovano fondamentalmente d’accordo su un punto, la sottomissione violenta delle loro dolci metà. “La civiltà di un paese si misura dal trattamento riservato alle donne” diceva non troppo tempo fa Hilary Clinton. Ma evidentemente in pochi la ascoltano o piuttosto tutti si sono abituati a convivere con “gradi” abbastanza bassi. Un po’ come nella città di Ubu, dove la crudeltà è efferata e la carneficina grottesca e dove sulla tragedia prevale il disgusto; oppure nella filmografia del controverso, antipatico e ultimamente alquanto dimenticato Gualtiero Jacopetti, dove quanto di peggio si potesse trovare in materia di donne e di violenza, di sadismo e di orrore, dall’Africa alla Polinesia alla Patagonia, finiva tutto puntualmente e disordinatamente affastellato, in crescendi bizzarri, esotici e crudeli che sfruttavano probabilmente l’effetto shock di immagini disordinate, volutamente “forti”, ma avevano anche colto un nervo scoperto nel contraddittorio rapporto tra tradizione e globalizzazione sfrenata, in fortissimo anticipo su tutti gli altri. Sandra Zorzi non ha mai amato le provocazioni di facile effetto e non ha mai cercato di cavalcare le mode dell’orrido ma sa tenere gli occhi aperti e, per senso di responsabilità, ha sempre cercato di fare in modo che, per quanto possibile, li aprissero anche gli altri.
Ha dovuto apparentemente e progressivamente dimenticarsi di regole più o meno esatte Alessandra Zorzi per rinforzare la sua necessità espressiva. Ovvero, quella parte della sua necessità espressiva che ormai da anni passa anche attraverso la tastiera di un computer. Anzi, attraverso la tastiera di un ordinatore come dicono molto più correttamente i francesi. Animazione, videoanimazione: questi gli epiteti prescelti per indicare come Alessandra Zorzi intenda far procedere nello spazio e nel tempo la sua indagine che, come conferma in questa stessa sede Martina Corgnati, “si colloca nel territorio dell’esercizio grafico e del colore, che l’intelligenza dell’artista rende però da subito sensibile e ricettivo nella nostra <civiltà ad alta tecnologia e refrattaria alle letture paludate e seriose ma, per contro, dipendente da una somministrazione quotidiana di visualità in altissimi dosaggi, che solo un secolo fa avrebbe tramortito e forse ucciso anche il più navigato e scaltrito degli uomini di mondo> ”. Animazione e videoanimazione che, com’è implicito anche se sempre più persone non lo ricordano, si basano proprio sulla possibilità del computer di ordinare qualsivoglia serie di dati, diventati codici binari che, nel nostro caso, si trasformano in segni che a loro volta si tramutano nel tempo dipanandosi in sequenza. Ogni immagine di milioni di dati infinitesimali perfettamente, matematicamente, algebricamente elaborati e quindi ordinatamente riprodotti anche quando, come nel nostro caso, fantasia, sarcasmo, surrealtà, ironia e provocazione amministrano linee narrative che negherebbero l’algido automatismo della capacità riproduttiva. Immagini perfino un po’ ripetitivamente riprodotte, almeno agli inizi. Quando, apprendista, Alessandra Zorzi, cercava di sfondare lo schermo gestendo la terza dimensione. Provando a far percorrere alla ora inquietante ora giocosa miriade dei suoi simil-personaggi (donne, soprattutto donne di saviniana inquietudine) una sorta di limbo sotterraneo, una galleria primordiale che potrebbe evocare le grotte dove, sacralizzandole con i loro voti e le loro paure, i nostri lontanissimo progenitori hanno identificato le prime immagini sopratutto d’animali scontornandole con argille e ossidi, dotandole intuitivamente, grazie al baluginio della luce finalmente riprodotta, dell’idea del movimento. Un limbo sotterraneo tridimensionale che poteva sfociare in mare aperto, anzi in un mare speculare ad un cielo che invece che tendere all’infinito dell’orizzonte, poteva diventare magnificamente claustrofobico accompagnando un umangatto nato da un uovo primordiale, ad una sorta di simposio elettivo con saccenti antichi e moderni capaci solo di diventare attendibili sul piano estetico. Perché, in realtà, fin dall’inizio dell’apprendistato (Girotondo negli abissi, Il pelo nell’uovo, 2004) Alessandra Zorzi, confrontandosi con la tastiera di un computer, ha cominciato a citare. Citando prima di tutto se stessa, ovvero interessando al passaggio in animazione o, meglio, in videoanimazione gli abitanti di quelle “realtà metropolitane a cavallo tra un fumetto per bambini, un film di fantascienza e un incubo notturno ” che poi sono i cardini della sua poetica altrimenti distribuita con le altre forme di creatività. Ma per perfezionare l’apprendistato Alessandra Zorzi prova a frequentare, riadattandole, se non reiventadole, altre forme grafiche, ordinandole con il computer ma pescando sempre in mondi tra il delirante e l’inquieto e ripercorrendo (dopo aver citato i capintesta degli storici visionari, da Hieronymus Bosch al Doganiere Russeau, ma senza dimenticare Michelangelo o Picasso) una sorta di storia del sopruso e della prevaricazione (Il sogno della ragione, 2005, il più narrativo tra i video). Arcimboldando, heartfieldando e maxernstando, ovvero riordinando in codice binario antiche e meno antiche eppur sapienti tecniche ora dell’allusiva sovrapposizione grafica di elementi congruenti, ora del patchwork di frammenti d’immagine derivati da un taglia e cuci virtuale di pittura, incisione, fotografia e quant’altro sia possibile ritagliare e ricomporre. Ed è su questa linea che poi prosegue quello che ormai, da apprendistato, sta diventando autentico video-mestiere, Alessandra Zorzi. Da Andrea Mantegna (2006) a Giocando con De Pero (2009) reinventano con leggerezza e coerenza temi d’ispirazione di cui la nostra si appropria personalizzandoli, in un gioco che oltre a penetrare la qualità espressiva di autentici maestri, ne erode, pezzetto per pezzetto, le costruzioni formali, quasi a volerli rubare per riciclarli, o, meglio, a volerli sceccherare per amalgamarli in una mistura di sapore alternativo. Ma continuando a provare e a riprovare. Per capire quando l’apprendistato, diventato video-mestiere, perfezionava uno stile, un’imprinting definitivamente maturo, personale e preciso, che pur rifacendosi a quella matrice pittorica evocatrice di favole all’apparenza leggere ma sostanzialmente di lucida analisi del contemporaneo anche ma non soltanto al femminile, trovasse nell’ animazione e videoanimazione una forma compiuta e non parallela o correlata. E a questo Alessandra Zorzi è sicuramente arrivata, semplificando e decantando alcune complessità iniziali (frutto delle regole dell’ordinare…)con le ultime opere. La prima, perfino, paradossalmente, silenziosamente ispirata dalla poesia di Andrea Zanzotto (versi da Papaveri, Il viaggio di Prometea, 2008) perfino infantile nella felicissima invenzione grafica di un mondo primordiale in costante evoluzione, nella sua adattabilità umana tutta tesa però, e non senza incertezze labirintiche, alla salvaguardia dei valori più incontrovertibilmente puri. La seconda, sfacciata metafora della vita, incasellata in un incastro di contenitori esemplarmente occupati dai vizi del vivere, ma impossibili da esorcizzare, anche impiegando esperienza e buon senso. Come conferma Martina Corgnati: “Sandra Zorzi appartiene ad una categoria d’ artisti infrequente se non rara, non gli “irascibili” (come si definiva Pollock) ma gli ironici, cioè di coloro che esigono da se e dalla propria arte che sia un linguaggio profondamente “responsabile” di fronte a se stesso e all’epoca in cui si esprime ”. Ma quel che conta è che per far questo Sandra Zorzi si serve in autonoma continuità sia dell’espressività collegata alle tele, agli arazzi, alla pittura in senso lato che di animazione e videoanimazione: sornione e disincantato Giorni di pulizie (2009) ne è l’esempio più lampante.
Gabbie per signora sono quadri efficaci, costruiti con una semplicità quasi illustrativa e tuttavia ricchi di delicate attenzioni pittoriche che contrastano con la brutalitàdidascalica del soggetto: “signore” dalle mucose dilatate a dismisura, il collo stirato, i metatarsi spezzati, il corpo intero imprigionato dentro una specie di birillo nero che a uno sguardo più attento si rivela nient’altro che un burka. Altrove, gli strumenti di torture antiche spacciate per culture si ritrovano graziosamente tutti insieme, come elementi di una natura morta fiamminga. Qualche volta invece moderno e antico sono posti a confronto perché si incontrino, oltre alle circostanze temporali, in pratiche sempreverdi: così scopriamo che gli interventi per la deformazione del piattello labiale si apparenta a quella del taglio della lingua, applicato per esempio a fattucchiere, streghe e ad imperatori bizantini spodestati secoli e secoli fa (ma da qualche parte ancora adesso). Eppure, incroci di segni e di sensi terrificanti come questi fra le mani di Sandra Zorzi acquistano un aspetto bizzarro, leggero e quasi giocoso, condiviso da certe damine vagamente ottocentesche, letteralmente prigioniere sotto alle loro immense crinoline (un lavoro che ricorda naturalmente il frustrante e pericoloso Telecommande di Jana Sterbak). La sua programmatica leggerezza scansa l’effetto d’orrore e ci invita invece ad affondare lo sguardo in modo da permetterci di vedere. Una strategia, potremmo dire, opposta a quella simulacrale praticata da molti artisti fra i più gettonati del mondo, che hanno scelto di cavalcare invece l’aspetto più conturbante, più controverso e più impressionante di opere-simulacro, a metà strada fra realtà e finzione, per intorbidare le acque dell’immaginario collettivo e compromettere la nitidezza del confine fra vero e falso, fra rappresentazione e verità. A Sandra Zorzi tutto questo non piace molto: come ho già avuto occasione di scrivere anni or sono, presentandola in grandi antologiche alla Galleria d’Arte Moderna di Spoleto e più tardi al Palazzo Ducale di Mantova, l’origine della sua ricerca artistica si colloca tutta pienamente e solidamente nel territorio dell’esercizio grafico e pittorico, del disegno e del colore, che l’intelligenza dell’artista rende però da subito sensibile e ricettivo nei confronti della nostra “civiltà ad alta tecnologia e refrattaria alle letture paludate e seriose ma, per contro, dipendente da una somministrazione quotidiana di visualità in altissimi dosaggi, che solo un secolo fa avrebbe tramortito e forse ucciso anche il più navigato e scaltrito degli uomini di mondo”. Sono nati da questa attitudine sincretistica, che coinvolge passione per l’arte e attenzione per il presente, i grandi arazzi pensati come filtri di luce, schermi di immagine trasparente o traslucida, le riflessioni grafiche sulle creature di sintesi che popolano il nostro immaginario e i nostri monitor, mostri e fantocci germinati da fantasie antiche e moderne, gli ibridi e i cloni che hanno popolato quadri come video d’animazione, disegni, e sperimentazioni grafiche, carte e tele e tutti gli altri oggetti in cui si dispiega la fervida fantasia di Sandra Zorzi. E continuano a nascere oggi le signore in gabbia, mostruose deformazioni delle civiltà di tutti i tempi e le latitudini, trattate però come graziose comparse di un romanzo a puntate, piacevole e ricreativo; i minotauri bambini, che fanno convivere miti micenei e cretesi con mutanti e aberrazioni dell’ingegneria genetica, i claustrofobici giardini di carni intrecciate, le rivisitazioni mirate di superstar e mostri sacri del mondo dell’arte e della cultura, da Fortunato Depero a Bruno Munari, da Andrea Mantegna a Leonardo da Vinci. E altre imprevedibili parodie. Ma soprattutto nasce da questo sincretismo inevitabile il gusto che porta la Zorzi a miscelare continuamente “contenuti” terribili e paurosi con uno stile giocoso e accogliente, quasi da illustrazione, o talvolta da graffitista. Le sue città tentacolari, le sue decadute Babelopoli piene di armi a doppio taglio, di equivoci simboli pseudo-religiosi, di creature controverse, metamorfiche e fumettistiche parenti strettissime di quelle altre che abitano i suoi video d’animazione, sono visioni che continuano senz’altro oltre la cornice della tela (la produzione di tanti video, secondo me, a parte il piacere del mezzo e la bisogno di abitare il suo/nostro tempo, risponde anche all’esigenza di superare i limiti della superficie, sconfinare, fare di più), potenzialmente all’infinito, dappertutto; i suoi affascinanti giardini organici, memori di Arp e di Sebastian Matta, delle calligrafie di Masson e delle tenebrose foreste di Wilfredo Lam, non hanno un centro e non ammettono vuoti fra un rizoma e l’altro, fra un’efflorescenza e una pianta carnivora. Si tratta di opere, in altre parole, che sembrano fatte per vivere nello spazio urbano, che premono per uscire dal quadro e invadere in qualche modo le coscienze barcollanti e distratte di cui il nostro tempo è troppo pieno. Non a caso gli arazzi, la cui bella famiglia si è appena arricchita di diversi, nuovi, variopinti ed esuberanti soggetti, sono appunto elementi che si sottraggono alla posizione ornamentale del quadro appeso alla parete, per scendere invece direttamente in campo e occupare lo spazio reale, quello che abitiamo noi, costringendoci, o talvolta più discretamente invitandoci, a un dialogo serrato, a un confronto fisico, a perderci fra un’immagine e l’altra, come in una specie di artificiale natura. Sandra Zorzi appartiene ad una categoria di artisti infrequente se non rara, non gli “irascibili” (come si definiva Pollock) ma gli ironici, cioè di coloro che esigono da se e dalla propria arte che sia un linguaggio profondamente “responsabile” di fronte a sé stesso e all’epoca in cui si esprime. Infatti, come alcuni surrealisti e dadaisti o, per restare in Italia, per esempio come Enrico Baj, Sandra Zorzi non si sottrae mai ad una certa, sensibile urgenza di rappresentazione del mondo, o se si preferisce non elude mai il problema dell’uomo, anzi, oggi soprattutto della donna di questo pianeta globalizzato, caotico e dimentico delle prospettive umanistiche che i nostri simili avevano annunciato a più riprese secoli fa. Ironia significa libertà inventiva, sperimentazione, apertura, ma anche responsabilità, anche impegno e anche volontà e capacità di mettersi in gioco, di indignarsi,di stupirsi, di continuare a pensare e a cercare di fare in modo che l’arte abbia un proprio posto nel mondo, ricopra un ruolo nella battaglia per la civiltà che, inaspettatamente, ci sembra orribilmente minacciata e da più parti. Qualche anno fa scrivevo che”le spoglie di Sandra sono sempre mentite e che dietro ai discorsi apparentemente leggeri nel suo lavoro fanno capolino problemi importanti e questioni chiave della nostra civiltà contemporanea”. Per fortuna era ed è ancora così. E oggi, in un sistema dell’arte più che mai onnivoro, polimorfo, disomogeneo ed eclettico, si dimostrano importanti e fanno scuola la continuità del suo impegno e la serenità leggera del suo linguaggio visivo, quasi balsamica a confronto con la pesantezza e la provocazione facile di tanta arte contemporanea, i cui scandali durano pochissimo, giusto fino al successivo, per poi essere tranquillamente dimenticati. Invece la forza dell’arte forse sta ancora, entro certi limiti, nella sua possibilità di contatto destabilizzante col mondo; un contatto caustico, eversivo, progettuale cioè maieutico, cioè critico. E a questo, proprio a questo, Sandra Zorzi non ha mai rinunciato.
Lo stile è ormai e compiutamente una strategia comunicativa. Non vi è oggi artista degno di tal nome che non l’abbia sperimentato sulla propria pelle (o per dir meglio sulla pelle del proprio linguaggio). Non vi è più, infatti, un solo linguaggio visuale che possa essere adottato spensieratamente senza diventarne vittima (che lo si assuma come eredità del proprio maestro o del contesto visuale in cui si è cresciuti o per tante altre determinazioni che chiamerei “pigre”). In tal senso, se non si pongono la questione di come calibrare il proprio stile per renderlo il più efficace possibile in termini di comunicazione, i seguaci di Duchamp o di Damien Hirst non sono meno obsoleti dei madonnari in ritardo. Il punto è che tutti gli stili sono stili del passato e il rincorrere quello che si ritiene più “contemporaneo” è processo rapido per essere tagliati fuori…dalla contemporaneità in accelerazione. Tant’è che nessuno è più in grado di rispondere a una domanda lecita sino a poco tempo fa: che stile devo adottare per essere di moda? Di moda, infatti, lo è l’arte contemporanea nel suo insieme e nella sua fase compiutamente eclettica. E chi se lo sarebbe mai aspettato?